ha anche il suo bravo nome da femmina

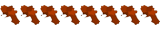





Fabietto17 ha scritto:Nei prox gg ci verrà anche a fare visita


Picentino27 ha scritto:CML - Centro Meteo Lombardo
DIDATTICA METEO ➡ Quando la NEVE palesa i microclimi!
Le precipitazioni nevose, a differenza della pioggia, hanno la particolarità di evidenziare con molta chiarezza le differenze microclimatiche del territorio in cui si manifestano. In occasione di una perturbazione invernale, una porzione di territorio che - a parità di quota - riceve una quantità inferiore di neve al suolo è facilmente identificabile a vista, specie in fase di fusione. Tale disomogeneità può dipendere da temperature al suolo localmente più alte e/o da un minore precipitato complessivo in millimetri equivalenti.
Mercoledì 16 marzo la provincia di Cuneo è stata interessata da nevicate diffuse sino a quote di fondovalle. Le immagini satellitari di venerdì 18 marzo (Modis/NASA) ci consentono di stimare a colpo d'occhio, con buona approssimazione, le zone maggiormente interessate dalle precipitazioni nevose. Nel primo fondovalle a nord di Cuneo, più o meno in prossimità della città di Busca, possiamo riconoscere un'area relativamente ampia (evidenziata in foto dal cerchio) dove la coltre nevosa si è già completamente fusa, a differenza del circondario dove invece, pur a quote altimetriche inferiori, persiste ancora una copertura nevosa discreta e uniforme. La ragione di questa singolarità è molto semplice. In quella zona "sfortunata", in occasione del maltempo di mercoledì scorso, sono caduti molti meno centimetri di neve rispetto al resto della piana più a levante, fatto che l'ha resa una delle prime aree pedemontane a fondere l'intero cumulato, esponendo le verdi campagne all'occhio vigile del satellite. Ciò detto... eccoci alla domanda da un milione di dollari: perché mai, proprio lì e solo lì in tutto il fondovalle cuneese, è nevicato sensibilmente di meno?
La risposta a questa domanda non è banale. Fortuna vuole che un fenomeno analogo sia regolarmente osservabile in alcune aree pedemontane lombarde, ad esempio nella convalle lecchese, nonché - in modo ancora più caratteristico - nella pedemontana veronese, ai piedi dei monti Lessini. A prescindere dalla zona coinvolta, il fenomeno atmosferico è sempre il medesimo e gli ingredienti sono sostanzialmente due: il vento e le montagne. Gran parte delle perturbazioni che raggiungono il Nord Italia generano in Valpadana venti di richiamo nei bassi strati atmosferici, a conseguenza di minimi di pressione al suolo che - tipicamente - vanno ad approfondirsi sulle pianure sottovento alla grande catena alpina (minimi "orografici"). La posizione di questi fulcri di bassa pressione, che veicolano flussi d'aria a circolazione ciclonica, determina la direzione locale dei venti in prossimità del suolo. In occasione della perturbazione di mercoledì (goccia fredda oltralpe in moto retrogrado dall'Austria alla Francia), un minimo barico padano s'è rapidamente strutturato sul basso Piemonte sud-orientale, proprio a ridosso delle Alpi Marittime, così come normalmente accade in configurazioni sinottiche analoghe. Va da sé che la ventilazione "di richiamo" nelle Valli di Cuneo s'è disposta in via prevalente dai quadranti nord-occidentali (i venti di bassa troposfera, per compensazione barica, soffiano in direzione dei centri di bassa pressione). Se osserviamo con attenzione l'orografia delle prime catene montuose a nord-nord-ovest di Cuneo non è difficile notare due distinti promontori, che di fatto cingono lungo i paralleli la porzione inferiore della Valle Varaita. Nel loro ultimo tratto si delineano due rilievi montuosi a penisola, alti circa mille metri, che si addentrano verso levante nelle piane cuneesi per una dozzina di kilometri in più rispetto al comune profilo pedemontano. Proprio quei promontori sono i responsabili di quanto siamo a illustrarvi nel presente articolo.
Le correnti di richiamo di bassa quota da nord-ovest, trovandosi ostacolate da queste naturali barriere, attivano localmente un effetto favonico nel versante sud-orientale sottovento, più o meno da Verzuolo a Busca e Dronero, mentre le piane più a est, poste a quote altimetriche addirittura inferiori (per intenderci da Saluzzo verso Savigliano e Fossano), non ne vengono coinvolte in quanto prive di rilievi a ridosso nella direzione da cui provengono i venti di richiamo. Il risultato è una netta, evidente differenza microclimatica tra queste due aree, topograficamente analoghe (entrambe di fondovalle) ma rispondenti a una dinamica di bassa troposfera sensibilmente diversa. Quali effetti determina una locale compressione favonica? In due parole, le masse d'aria che vanno ad occupare in regime turbolento i versanti sottovento si seccano e si riscaldano, alimentando altresì una sostenuta ventilazione a tutte le quote impegnate, con componenti sia orizzontali sia verticali (moti discendenti, catabatici). Tale dinamica porta sostanzialmente due effetti: le precipitazioni si riducono in maniera significativa e il gradiente termico verticale aumenta, innalzando gioco forza le temperature al suolo e limitando l'opportunità di preservare una colonna omotermica di bassa troposfera. In caso di precipitazioni nevose con campo termico "al limite" (attorno agli zero gradi), è facile comprendere come lo scenario appena descritto sia deleterio per lo sviluppo e la "sopravvivenza" dei fiocchi: ne cadono di meno, ne fondono di più.
Desideriamo, in ultimo, mostrarvi qualcosa che - senza mezzi termini - ci ha lasciati di stucco. Uno dei modelli matematici di previsione tra i più sofisticati a nostra disposizione (AROME Météo-France) è talmente efficace nell'interpretazione dell'orografia al punto di accorgersi di questo fenomeno con una precisione a dir poco sbalorditiva. Nel quadro di previsione emesso martedì 15 marzo alle ore 12Z, nel quale il modello stima i centimetri di neve accumulati al suolo nelle successive 24 ore, è imbarazzante notare la correlazione con quanto poi effettivamente occorso. La porzione di fondovalle sottovento, nel circondario della città di Busca, viene correttamente identificata entro a un minimo locale d'accumulo nevoso. Questi strumenti - quasi "magici" - consentono finalmente a noi previsori di stilare bollettini ricchi di dettagli fino a poco tempo fa nemmeno immaginabili. Seppur nel breve termine, la modellistica previsionale sta iniziando a guadagnare un sensibilità davvero significativa. E' uno strumento prezioso che ci consente di migliorare la lettura degli infiniti microclimi che caratterizzano un territorio sì vasto e complesso come il nostro.




Giglio rosso ha scritto:analisi impeccabile, complimenti sinceri picentino.
ho assistito anche io a fenomeni del genere, in caso piu didattico al riguardo e stato quando nel gennaio 2002 dall'alto dei colli che dominano montesarchio ( dove il manto nevoso raggiungeva i 38 cm a quote intorno ai 500 metri ) in una mattinata di sole ho visto con i miei occhi una piccola porzione del fondovalle caudino fra i paesi di bucciano, airola e il pedemonte di bonea, dei tutto sgombra di neve, laddove nel resto della valle caudina Montesarchio compresa l'accumulo raggiungeva anche i 20 cm, ( la zona di casa mia , non lontanissima dall'area sgombra di neve, presentava solo 4 cm al suolo)
in quel caso , vista l'uniformita delle precipitazioni, di tipo continuo , ho attribuito lo stacco a un leggero effetto favonico prodotto dalla protezione del taburno e dalla colline che sorgono a est della valle caudina e che proprio nel loro lembo piu settentrionale aumentano di quota ( monte mauro 656 m.s.m ) - ma sta in piedi perfettamente anche un altra ipotesi, ossia che la nevicata (almeno nella zona circostante casa mia ) laddove accompagnata da un leggero vento orientale e in presenza di temperature leggermente superiori allo zero fondesse a un ritmo maggiore rispetto a zone ( anche qui ho constatato di persona ) dove il vento era assente.
tutto questo in un contesto in cui le nevicate di quei giorni furono prodotte dal sovrascorrimento di due distinte perturbazioni atlantiche su un cuscino di aria fredda prodotto da settimane di gelo ininterrotto. ( non a caso in quei giorni ci fu un abbondante nevicata anche a benevento citta che e a una quota ben piu bassa di montesarchio )









noqot ha scritto:Interessante, ma non confonderei tempo e clima.
Bella e convincente spiegazione per il singolo episodio, ma ci vorranno molti altri eventi per trarre conclusioni climatiche certe circa la nevosità della zona, per quanto siano ipotizzabili in astratto.
Bella anche la prestazione del modello citato.




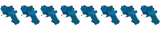


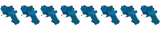


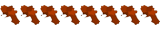


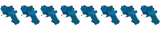
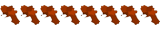





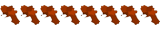






Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti